
Nei tempi in cui il gas e il petrolio non erano ancora stati introdotti il carbone era la principale fonte di energia, domestica e industriale. In montagna quello del carbonaio è stato un mestiere ampiamente diffuso fino alla metà del XX secolo.
La necessità di controllare costantemente la produzione del materiale delle carbonaie lo obbligava a vivere nel bosco per intere settimane di seguito, tagliato fuori dalla vita del paese e di conseguenza ai margini della società. E spesso con lui era l’intera famiglia. Un mestiere ingrato che richiedeva una grande abilità, un’arte, a detta di molti. Era un sapere complesso che doveva tener conto non solo della geometria nella costruzione della carbonaia, con i camini per lo sfiato del fumo, ma anche delle condizioni metereologiche, a partire dal vento. I carbonai italiani erano così abili nel loro mestiere che la loro competenza era molto apprezzata soprattutto in Corsica e in Brasile, motivo per cui molti, tra XIX e XX secolo, lasciavano il proprio paese e una vita di stenti e fatiche per emigrare. Dalle nostre parti erano famosi i carbonai casentinesi, in particolare di Montemignaio, che si spostavano a lavorare anche nel versante romagnolo ed erano rinomati per la loro bravura “… facevano un carbone… che sonava!”, come ci ha raccontato un ex abitante di Pietrapazza riferendosi ai carbonai toscani.
La lunga procedura cominciava con la creazione della “piazza” per la cottura del carbone, un piano di terreno circolare senza pendenze dai 20 ai 40 metri quadrati circa, posto solitamente nei pressi dei sentieri per agevolare il trasporto della legna e del materiale finito. Ancora oggi si trovano le tracce di questi luoghi, che mantengono la forma rotondeggiante e soprattutto il terreno più scuro. Terminata la spianatura della piazza, il carbonaio piantava al centro tre pali della medesima lunghezza, circa due metri, formando così un piccolo triangolo, poi creava il camino della carbonaia realizzando due piccoli cerchi attaccati ai pali ad altezze diverse.
Intorno al camino si cominciava ad accumulare la legna ponendo i pezzi più grossi in basso e quelli più fini in alto, quando il primo piano aveva raggiunto un certo spessore si incominciava il secondo strato, partendo sempre dal centro, e così si procedeva fino a riempire tutta la piazza. Dopo di che si preparavano le “pellicce”, zolle erbose che venivano poste nella porzione inferiore della carbonaia con la parte terrosa verso l’esterno, si raccoglievano foglie umide da porre nella parte alta e poi si ricopriva il tutto con terra molto fina, lasciando aperta la bocca del camino nella quale si accendeva il fuoco.
Via via che la legna bruciava e la brace cadeva in fondo al camino, il carbonaio la rimboccava con legna tagliata, fino a quando tutto il camino si riempiva di brace, poi si ricopriva nuovamente il tutto con la terra, mentre con un bastone appuntito si aprivano alcuni buchi per la fuoriuscita del fumo nella parte alta della carbonaia.
Tutte queste procedure terminavano alla fine della prima giornata, dopo di che iniziava il processo di cottura vero e proprio durante il quale, sempre sorvegliato dal carbonaio, il fuoco piano piano trasformava la legna in carbone. Era un processo molto delicato perché se il fumo non usciva regolarmente la carbonaia si surriscaldava e prendeva fuoco. Dal colore del fumo il carbonaio capiva se dare o togliere aria alla carbonaia finché la legna perdeva tutta la sua umidità ed era il momento della “sermonda” cioè quando si ricompattavano le crepe che si formavano nella pelliccia riarsa. Infine, si lasciava raffreddare la carbonaia e la si apriva per raccogliere il carbone, con l’utilizzo dei rastrelli, per dividerlo dalla terra. Poi il carbone veniva insaccato e si attendeva l’arrivo dei vetturini, altra interessante e quasi completamente scomparsa attività, che provvedevano al trasporto.
Ad assistere i carbonai la figura, quasi romantica, del “Meo”, un ragazzino che fungeva da aiutante e doveva sorbirsi i rimbrotti dei carbonai, come testimoniato in una canzone in ottava rima della montagna pistoiese, di cui si riporta l’ultima ottava:
L’aria è chiara, tiepida e leggera,
la campagna di fiori e d’erbe è ornata.
Canta quell’usignol con buon maniera
la canzone del meo addolorata.
Inneggia e canta la natura intera,
inneggia alla campagna terminata.
Io d’arrivare in fondo non credéo.
Dio mi riguardi di rifarlo il meo.
(tratto da Aimo Mucci, I Forzati della Foresta, Gli Ori, Pistoia 2006)
Foto di Pier Paolo Zani, tratte dalla pubblicazione “I carbonai. Un mestiere in bianco e nero” di Pier Paolo Zani, Ed. Pazzini














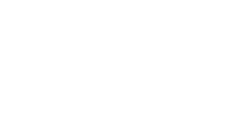


 Integra Solutions
Integra Solutions